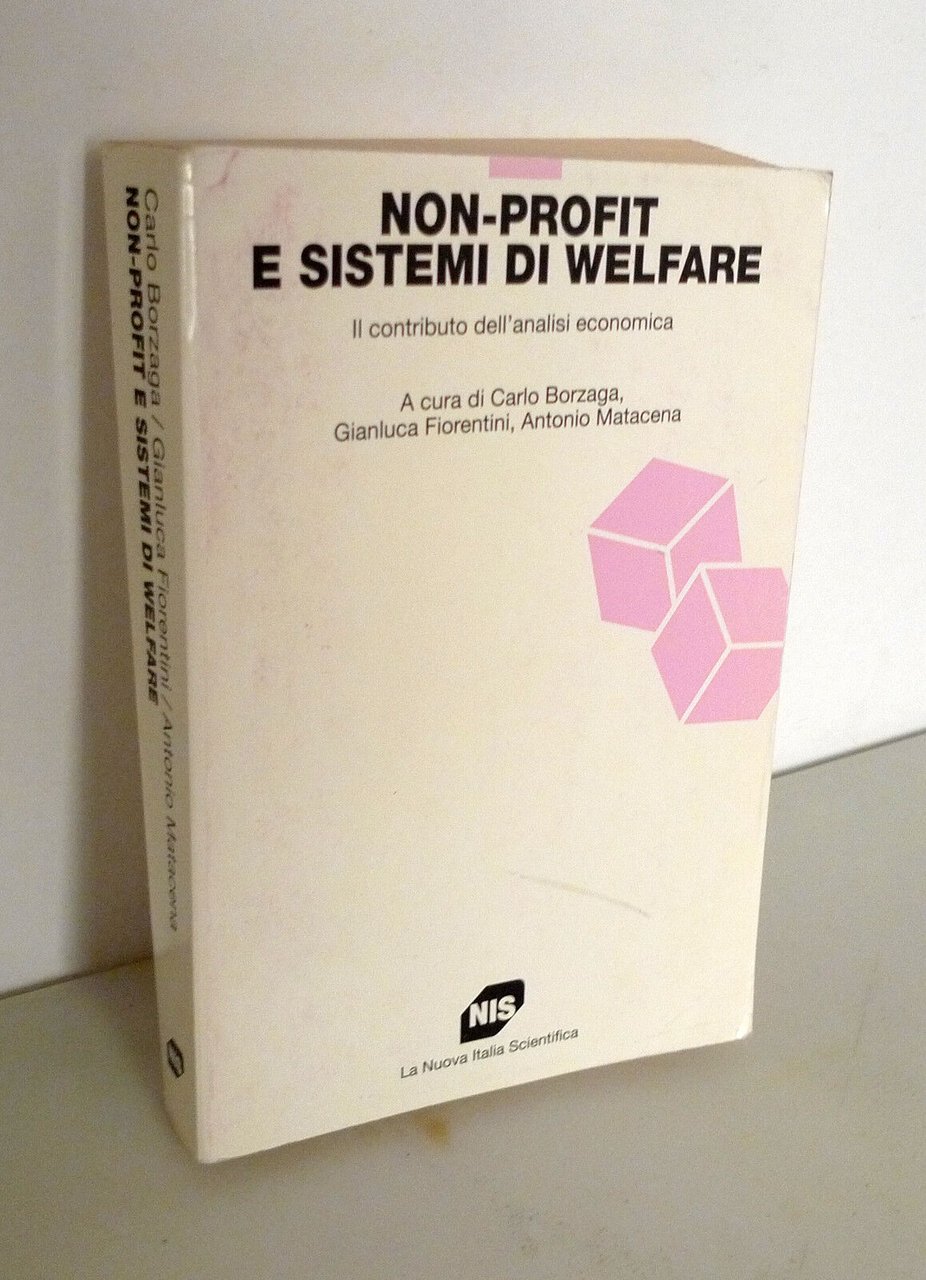Borzaga,NON-PROFIT E SISTEMI DI WELFARE,1996 NIS[economia sociale
Formas de Pago
- PayPal
- Tarjeta de crédito
- Transferencia Bancaria
- Pubblica amministrazione
- Carta del Docente
Detalles
Descripción
A cura di Carlo Borzaga, Gianluca Fiorentini,
Antonio Matacena,
NON-PROFIT E SISTEMI DI WELFARE.
Il contributo dell'analisi economica.
La Nuova Italia Scientifica, Roma 1996,
brossura, 22x15 cm, pp.446,
peso g.593
cod.2865
CONDIZIONI DEL LIBRO: buone,
segni di usura alla copertina,
note e sottolineature a matita
INDICE
Ringraziamenti 15
Introduzione 17
di Carlo Borzaga, Gianluca Fiorentini, Antonio Ma-
tacena
Parte prima
La privatizzazione dei sistemi di welfare:
cause, problemi e modalità
1. Perché e come privatizzare i sistemi di welfare 47
di Carlo Borzaga
1.1. Premessa 47
1.2. Le funzioni dei sistemi pubblici di welfare 49
1.3. Le possibili strategie di riforma e di privatizzazione 54
1.4. Privatizzazione dei sistemi di welfare ed evoluzione
della domanda 58
1.5. I modelli di privatizzazione e le condizioni del loro
successo 60
1.6. Le politiche necessarie per la privatizzazione dei ser-
vizi di welfare 63
1.7. L’evoluzione del settore non-profit 64
1.8. Conclusioni 68
Riferimenti bibliografici 69
Il contributo della teoria economica ai processi di
privatizzazione nei servizi sociali 71
di Gianluca Fiorentini
Introduzione 71
Efficienza nei mercati per i servizi sociali 72
2.2.1. Fonti di inefficienza nella fornitura di servizi sociali / 2.2.2. Fonti di
inefficienza nei mercati assicurativi / 2.2.3. Servizi sociali come beni di
merito
Le modalità dell’intervento pubblico 79
2.3.1. La fornitura pubblica diretta di servizi sociali / 2.3.2. La fornitura
privata in presenza di regolamentazione pubblica
Problemi dei meccanismi di decisione collettiva 88
2.4.1. Inefficienze intrinseche nelle decisioni collettive / 2.4.2. Inefficienze
nella realizzazione delle decisioni collettive / 2.4.3. Inefficienze comuni ai
meccanismi allocativi di mercato
Conclusioni: la dottrina del vantaggio comparato 100
Riferimenti bibliografici 104
Sul contracting-out nei servizi sociali 105
di Gian Paolo Barbetta
Introduzione e conclusioni 105
Gli strumenti della privatizzazione: principali alterna-
tive 107
Il contracting-out 113
3.3.1. Evocare prima di descrivere: un caso / 3.3.2. Le ragioni “storiche”
del contracting-out / 3.3.3. Le ragioni “teoriche” del contracting-out / 3.3.4.
Le condizioni per un contracting-out efficiente / 3.3.5. I problemi del con-
tracting-out / 3.3.6. Informazione e forma istituzionale del venditore / 3.3.7.
Prestazioni e struttura delle remunerazioni
Contracting-out e convenzioni nei servizi sociali in
Italia 127
Riferimenti bibliografici 130
Quasi-mercati, imprese non-profit e razionalità li-
mitata 131
di Luigi Mittone
Premessa 131
I quasi-mercati e i limiti delle riforme: è vera con-
correnza? 132
4.2.1. Libero accesso dei produttori al mercato / 4.2.2. Il principio della
massimizzazione dei profitti / 4.2.3. Il livello dei prezzi è tale per cui la
domanda uguaglia l’offerta per tutti i mercati
I quasi-mercati: il lato della domanda 147
Il ruolo delle organizzazioni non-profit nella riforma
dei quasi-mercati 154
Conclusioni 157
Riferimenti bibliografici 158
Parte seconda
L’analisi economica delle organizzazioni non-profit
e i processi di privatizzazione nei servizi collettivi
L’analisi economica e le organizzazioni non-profit:
alcuni riferimenti concettuali 163
di Laura Angeloni
Introduzione 163
Problemi definitori 165
5.2.1. Disomogeneità nel linguaggio / 5.2.2. Definizioni basate sull’indivi-
duazione dei soggetti giuridici / 5.2.3. Definizione basata sull’individuazio-
ne delle attività / 5.2.4. Definizione basata sulle finalità o funzioni / 5.2.5.
Definizione basata su criteri multipli / 5.2.6. Organizzazioni con finalità
mutualistiche e altruistiche
Giustificazioni economiche all’esistenza delle organiz-
zazioni non-profit 176
5.3.1. Teorie della domanda / 5.3.2. Teorie dell’offerta / 5.3.3. Considerazio-
ni conclusive
Teorie economiche come giustificazione di agevolazio-
ni fiscali 191
I rapporti tra settore pubblico e settore non-profit
alla luce della teoria economica 194
Riferimenti bibliografici 199
6. Un modello di osservazione economico-aziendale per
le aziende non-profit 203
di Michele Andreaus
6.1. Premessa 203
6.2. Evoluzione del concetto di azienda:alcune note in-
troduttive 204
6.3. La nascita dell’economia aziendale 209
6.3.1. Verso una ridefinizione dell’azienda / 6.3.2. L’azienda come entità
socio-economica
6.4. ONP o ANP? Un possibile inquadramento teorico 223
6.4.1. Il difficile rapporto tra economicità e socialità nell’economia azien-
dale
6.5. Conclusioni 234
Riferimenti bibliografici 235
7. Uno schema di classificazione delle organizzazioni
non-profit 241
di Antonello Zangrandi
7.1. Premessa 241
7.2. La funzione e il servizio: uno schema di riferimento
per comprendere il funzionamento degli enti pubblici 245
7.2.1. La cessione dei beni e dei servizi / 7.2.2. Le relazioni finanziarie /
7.2.3. La cooperazione professionale, scientifica e sui bisogni / 7.2.4. Le
relazioni istituzionali / 7.2.5. Le relazioni non istituzionali
7.3. Le condizioni di economicità 252
7.4. Le formule gestionali per i servizi sociali 255
Riferimenti bibliografici 258
Parte terza
L’efficienza nella produzione di servizi di interesse collettivo
in un’ottica comparata
8 Analisi di efficienza per organizzazioni non-profit 261
di Laura Angeloni, Gianluca Fiorentini
8.1. Introduzione 261
8.2. Problemi definitori 262
8.2.1. L’approccio di Scherer / 8.2.2. L’approccio di Pestieau-Tulkens
8.3. Definizioni di efficienza 266
8.4. La determinazione degli ottimi di produzione 268
8.4.1. Efficienza e funzioni di costo / 8.4.2. Efficienza e mutamento tecno-
logico
8.5. Efficienza e numeri indice 273
8.5.1. L’aggregazione degli indici
8.6. Le frontiere di produzione 279
8.6.1. Frontiere parametriche / 8.6.2. Frontiere non parametriche
8.7. Evidenza empirica 286
8.7.1. Indici di efficienza / 8.7.2. Frontiere di produzione
8.8. Problemi pratici nella stima dell’efficienza delle or-
ganizzazioni non-profit 294
Riferimenti bibliografici 296
9. Un modello di osservazione economico-aziendale di
unità di produzione e di erogazione di servizi sociali 299
di Claudio Travaglini
9.1. I centri socio-educativi della Regione Lombardia e i
servizi semiresidenziali per handicappati. I criteri di
finanziamento 303
9.2. Le case protette della Regione Emilia-Romagna e i
servizi assistenziali residenziali per anziani non auto-
sufficienti. La valutazione dell’autosufficienza degli
ospiti 310
9.3. I criteri per la classificazione delle strutture e l’ero-
gazione dei contributi 314
9.4. L’analisi dei costi e dei servizi prodotti da un grup-
po di aziende 316
9.5. I costi di gestione e le informazioni sull’attività delle
case protette 319
9.6. I costi di gestione e le informazioni sull’attività dei
centri socio-educativi 324
9.7. Alcune considerazioni conclusive 329
Riferimenti bibliografici 331
Parte quarta
La rilevazione delle preferenze individuali
nei confronti dei servizi collettivi: il caso di Forlì
10. La misurazione delle preferenze individuali per beni
pubblici e beni di merito: una rassegna sulle appli-
cazioni 335
di Laura Angeloni, Gianluca Fiorentini
10.1 Introduzione 335
10.2 Metodi di misurazione delle preferenze 337
10.3 Metodi indiretti e situazioni reali 339
10.4 Metodi indiretti e scenari ipotetici 347
10.5 Metodi diretti e situazioni reali 348
10.6 Metodi diretti e scenari ipotetici 350
10.7 I giochi di allocazione di bilancio 355
10.8 Costruzione del questionario 357
10.9 Conclusioni 358
Riferimenti bibliografici 359
Appendice 362
11. Un gioco di allocazione del bilancio a due stadi:
un’analisi della domanda dei servizi sociali 365
di Gianluca Fiorentini
11.1 Introduzione 365
11.2 Aspetti di metodo e disegno della ricerca 366
11.3 Le caratteristiche generali del campione intervistato 368
11.3.1. Le caratteristiche del campione / 11.3.2. Le preferenze nei confronti
dell’intervento pubblico nel suo complesso
11.4 Le preferenze rispetto alla composizione della spesa 377
11.5 Le preferenze rispetto alla composizione delle en-
trate 386
11.6 Le preferenze rispetto alla spesa per assistenza 390
11.7 II votante mediano come modello di previsione 396
11.8 Conclusioni 399
Riferimenti bibliografici 400
Appendice 401
12. Un’analisi della segmentazione delle preferenze fiscali
all’interno di un gioco di allocazione di bilancio 405
di Furio Camillo, Gianluca Fiorentini
12.1. Introduzione 405
12.2. Metodologia di campionamento 406
12.2.1. Il metodo di ponderazione del campione
12.3. Cenni sulla metodologia di analisi dei dati 410
12.4. Descrizione dei gruppi 414
12.4.1. Gruppo 1: i soddisfatti dello status quo / 12.4.2. Gruppo 2: i cerca-
tori di rendite / 12.4.3. Gruppo 3: i giovani emergenti / 12.4.4. Gruppo 4:
i giovani non emergenti / 12.4.5. Gruppo 5: gli anziani conservatori
12.5. Le relazioni tra gruppi e voci di bilancio 427
12.6. Conclusioni 428
Riferimenti bibliografici 429
Appendice A 430
Appendice B 437